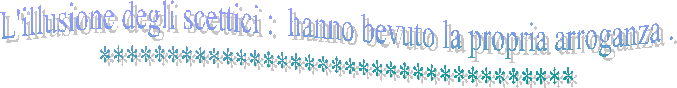
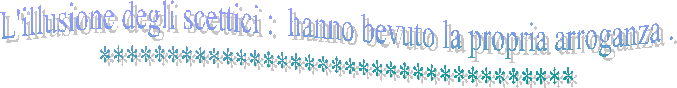
La realtà fisica è smisuratamente vasta ma delimitata, lo spazio – tempo è illimitato tuttavia finito, poiché è di natura energetica; esistono molti universi, probabilmente incommensurabili che si aprono a dimensioni straordinarie, come interminabili piani paralleli di realtà diverse forse interagenti.
![]()
La nostra mente non potrà mai raffigurarsi tutto quello che non è rappresentabile con i sensi, scene d’indescrivibile bellezza saranno per noi soltanto tracce, emanazioni luminose inaccessibili. Nonostante i limiti biochimici parte della mente potrebbe proiettarsi oltre le attività neuronali, più in là di quelle filogenetiche, in realtà sovrapposte conservando tracce di memorie lontanissime passate o future (simmetria del tempo).
Nonostante la profonda ignoranza, la molecolare conoscenza
che abbiamo dello spazio fisico, molti uomini dotti con insolenza e tracotanza
si dichiarano i detentori del sapere universale, offendendo e ironizzando chi
tenta con umiltà la scalata del sapere. Io credo che lo scetticismo sia un modo
sterile di negare la realtà; 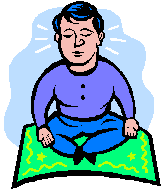
L’incredulo tende a tutti i costi ad autoaffermare se stesso, le sue verità, piuttosto di capire l’altro, approfondendo insieme realtà diverse apparentemente paradossali. Egli presume di conoscere ogni cosa, dando scarsamente ascolto a chi propone altre metodologie d’indagine. Segue inamovibile il suo ragionamento considerando la propria percezione del mondo l’unica verità, giudicando, invece, marginale qualsiasi altra visione che propone un cambiamento di prospettiva. Lo scettico non sopporta chi si discosta dal suo pensiero, per lui è inaccettabile il confronto, conosce soltanto la direzionalità della comunicazione e diffida di tutto ciò che possa in qualche modo mettere in crisi i suoi modelli interpretativi.
Ho letto diversi libri, molti articoli critici sul paranormale ed ho potuto costatare grossolani errori metodologici nei controlli riportati.
Gli autori (scettici) affermano che dalle loro verifiche hanno scoperto la falsità d’alcune testimonianze sui fenomeni prodigiosi, poiché qualcuno aveva truffato, dando per sensazionale un evento straordinario che era soltanto l’effetto di un’illusione o di un trucco. Fin qui le cose potevano andar bene, se si fossero limitati a smascherare un truffaldino o un illusionista, ma non avevano quest’intento, la loro posizione era ben diversa, alquanto ideologica, dovevano servirsi di quell’espediente per smentire tutti i possibili eventi non codificabili dalla fisica sperimentale, assumendo la propria prospettiva d’indagine, come l’unica verità assoluta.
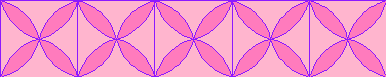
Così hanno generalizzato quegli episodi a tutti i probabili avvenimenti non spiegabili dalla scienza classica: manierismo d’onnipotenza. Ogni evento ESP era per loro solo il risultato di farneticazioni, racconti di psicotici o d’impostori, o trucchi, o inganni dei sensi! Tutti i fenomeni ESP erano il risultato di truffe, abbagli, miraggi; non poteva sussistere per loro alcuna eventualità alternativa all’illusione, all’imbroglio, davano per scontato in funzione d’alcuni casi studiati, che nessun altro avvenimento ESP potesse essere di natura diversa, ci sarebbe stata da qualche parte una spiegazione banale del fenomeno, bisognava solo trovarla.

Questo modo d’inferire appartiene ad una categoria della mente che è stata considerata dagli psicologi cognitivisti una distorsione del pensiero; ogni volta che si generalizza una situazione di truffa o d’aberrazione percettiva a tutti i possibili eventi prodigiosi, si determina una scorrettezza del pensiero. La conclusione alla quale si giunge non potrà mai essere corretta, poiché s’inferisce sulla particolarità di qualche circostanza poco chiara e volutamente ricercata e non su tutte le variabili in gioco. Esiste una letteratura, un reportage di casi plurisecolari che affonda le proprie radici alle origini dell’uomo. Su quali capisaldi possono gli illustri personaggi affermare che tutte le testimonianze documentate dalla storia siano soltanto illusorie o false, e che solo le loro ricerche siano quelle metodologicamente giuste?
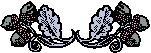
Inoltre, lo scettico, considerando di poco conto qualsiasi evento che possa dimostrare l’infondatezza della sua ragione, esamina soltanto le variabili che giustificano la propria tesi, non vagliando o considerando irrilevanti quelle che possono confutarla. Egli ha bisogno dei maghi, dei mistificatori, degl’illusionisti per selezionare gli elementi che gli servono per negare l’evidenza d’altre realtà, può, così, usurpare a Dio il diritto assoluto di verità, definendo ciarlatano chi afferma il contrario. La sua ricerca è contaminata da un presumere che non gli permetterà mai di trovare la pietra filosofale, in altre parole la negazione del mistero.
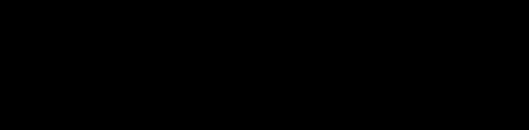
La consapevolezza di questi scettici o presunti uomini del
sapere onnisciente, nasce da un presagire totalizzante, che non ammette nessuna
contraddizione; una pulsione di negare, di godere affermando che soltanto l’antropocentrismo
di un solo modello interpretativo del reale sia l’unico modo possibile di
procedere. Ci sta un vizio di fondo, una metodologia inopportuna, inadeguata,
che se risponde alla comprensione d’alcune leggi naturali, né elude l’intendimento
di altre. Molti 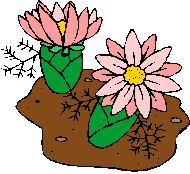 scettici del
paranormale ripropongono modelli di verità medioevali, in questo modo depongono
la morte del sapere, riaccendono roghi simbolici dove incendiamo la pura
conoscenza, quella della ricerca senza riserve.
scettici del
paranormale ripropongono modelli di verità medioevali, in questo modo depongono
la morte del sapere, riaccendono roghi simbolici dove incendiamo la pura
conoscenza, quella della ricerca senza riserve.
Esistono modi incommensurabili di indagare una realtà (non sola fisica) che è altrettanto infinita, ove esistono eventi singolari, rari, poco controllabili da una ragione che vorrebbe essere detentrice del sapere. Gli scettici confutano la possibilità che un fenomeno diverso non misurabile o computabile possa esistere, in questo modo, negandone la ragione d’essere, si pongono come Dio, infiniti nella conoscenza.
Non credo affatto alla loro natura divina o faraonica, poiché sono uomini, individui immodesti che rifiutano il confronto, così danno spazio alla credulità per reazione opposta. Nessuna conoscenza è inesauribile, nessuna teoria è eterna, immacolata, insuperabile.

Nicolò Schepis